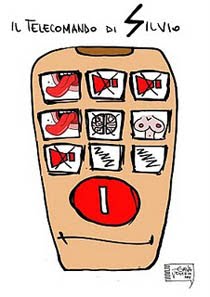di Tonino Bucci
A ricordare oggi i fatti del luglio 60, c'è di che riflettere sulla memoria pubblica di questo paese. Dalla scomparsa del Pci a oggi è pressoché sparita, dalla coscienza storica, degli italiani, ogni traccia degli eventi di quei giorni di cinquant' anni fa. Poco o nulla resta, sul piano simbolico, degli scioperi e delle manifestazioni popolari contro il governo allora guidato dal democristiano Fernando Tambroni, appoggiato dall'esterno dall'Msi. Una flebile traccia delle repressioni sanguinose della polizia contro i cortei operai rimane nella canzone politica. Eppure nessuno si meraviglierebbe se un ventenne di oggi, a differenza di un ventenne degli anni Settanta, non dovesse conoscere a menadito i versi cantati da Fausto Amodei in Per i morti di Reggio Emilia: «Compagno cittadino fratello partigiano / teniamoci per mano in questi giorni tristi / Di nuovo a Reggio Emilia di nuovo là in Sicilia / son morti dei compagni per mano dei fascisti».
Ma all'immaginario ventenne del nostro tempo non se ne può fare una colpa. Non è una responsabilità sua se la memoria pubblica ha smesso di trasmettersi da una generazione all'altra. Il meccanismo si è inceppato per cause che ben poco, anzi nulla hanno a che fare con l'indisponibilità soggettiva a conoscere come si sono svolti eventi altamente simbolici del nostro passato. Naturalmente, la scrittura della storia non è un atto neutrale. Come non vedere, ad esempio, la funzione politica del revisionismo storico di cui la destra italiana è stata principale artefice in questi ultimi decenni? Lo smantellamento della memoria resistenziale è andata di pari passo con la legittimiazione degli ex missini come personale di governo. «Chi controlla il passato, controlla il futuro, diceva Orwell. Di questa riscrittura della storia - per dirla con le parole di Paolo Ferrero che ieri ha presentato un ciclo di iniziative del Prc (1960-2010
La ricostruzione della storia italiana in chiave revisionistica è avvenuta anche per la miopia - o per la subalternità culturale - della sinistra moderata, «fin da quando Luciano Violante diede la stura per l'equiparazione tra partigiani e repubblichini». Leggiamoli più da vicino i fatti del luglio 60. Il 30 giugno di quell'anno c'è la convocazione del congresso dell'Msi a Genova, città medaglia d'oro alla Resistenza. C'è una fortissima mobilitazione operaia e popolare, in particolare i portuali. Ci sono scontri durissimi con la polizia, con morti e feriti. Lì c'è l'esordio di un nuovo protagonista, i ragazzi con le magliette a strisce. Nei giorni a seguire si svolgono anche in altre città manifestazioni popolari di protesta. Scendono nelle piazze lavoratori, sindacati, parlamentari dell'opposizione comunista e socialista. Intanto il livello della repressione da parte della polizia si fa durissimo. E' la fase di scontro nel paese più aspro dai tempi dell'attentato a Togliatti. Il 5 di luglio a Licata, in Sicilia, c'è una manifestazione contro il carovita e la disoccupazione. La polizia interviene e uccide un manifestante, accorso in aiuto di un bambino picchiato dalla Celere. Il sette luglio a Reggio Emilia la polizia carica un corteo contro il governo Tambroni e uccide cinque persone, cinque operai tutti iscritti al Pci. Della strage rimarrà il ricordo nei versi della canzone di Fausto Amodei, Per i morti di Reggio Emilia. Come pure resterà nella memoria collettiva l'immagine più nitida di quei tempi, quella dei caroselli delle jeep della Celere tra i manifestanti. L'8 luglio a Palermo c'è lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Un'altra carica della polizia, altri quattro morti. Nel pomeriggio per protesta si forma una manifestazione davanti al municipio. La polizia spara per disperdere i manifestanti. Ci sono trecento fermi, quaranta persone medicate per ferite da anni da fuoco. Sempre l'8 luglio, a Catania, per lo sciopero della Cgil, intervengono le forze dell'ordine. Un edile è massacrato a manganellate e finito con un colpo di pistola. Ci sono scontri anche a Roma dove è solo per caso che non ci scappa il morto. E' Raimondo d'Inzeo, un campione olimpionico di equitazione, oltre che comandante di un reggimento di carabinieri, a guidare la carica a cavallo su un corteo al quale partecipano anche parlamentari dell'opposizione. I contrasti crescono per anche all'interno della Dc. Dopo qualche giorno Tambroni si dimette e il governo cade. Questa è la storia, da qui iniziano le analogie tra presente e passato. «C'è una relazione - dice Ferrero - tra le battaglie di cinquant'anni fa e quelle che ci sono oggi, che di nuovo intrecciano la difesa della democrazia con le questioni sociali». Dalla protesta contro la legge-bavaglio alla resistenza degli operai di Pomigliano contro l'accordo-ricatto della Fiat c'è un sottile filo che ricorda lo scenario del luglio 1960. Con alcune differenze, certo. «Oggi la repressione si scatena più sulle figure marginali, come Cucchi e Aldovrandi», relegate alla cronaca quotidiana. Anche oggi, c'è un'emergenza sociale, «la disoccupazione tocca livelli altissimi, il disagio è forte ma, rispetto ad allora, non ha strade politiche in cui esprimersi efficacemente». Anche le forme della repressione - a differenza di cmquant'anni fa - sono più sofisticate. Pomigliano docet. «C'è stato un ricatto di tipo mafioso da parte della Fiat. Il ruolo dei mass media pure, è stato determinante nel costruire l'idea che non ci fossero alternative tra l'accettare l'accordo o perdere il posto di lavoro. Il risultato del referendum tra i lavoratori ha rispedito al mittente l'intera operazione». I segnali di un clima antioperaio ci sono tutti: «il governo dice che bisogna modificare l'articolo 41 della Costituzione e la parte sui rapporti sociali.
Di analogia in analogia, questa miscela tra gruppi industriali e destra politica rinvia di nuovo alle vicende di cinquant'anni fa. Anche allora il governo Tambroni non fu un fulmine a ciel sereno, per il semplice fatto che era l'espressione politica di una parte della società italiana, sostenuta da gruppi industriali è apparati della pubblica amministrazione. Dietro Tambroni c'era un'Italia che non aveva digerito
da Liberazione (25/06/2010)